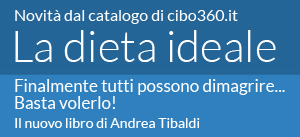Ginecomastia
Con il termine ginecomastia si definisce l'aumento volumetrico di una o entrambe le ghiandole mammarie maschili, per proliferazione non neoplastica dei dotti e dello stroma periduttale.
Le ginecomastie possono originare da cause fisiologiche, iatrogene o patologiche.
Patogenesi
Il meccanismo fondamentale della ginecomastia è rappresentato da una prevalenza assoluta o relativa dell'attività estrogenica sull'attività degli androgeni, che stimola quindi la crescita del tessuto mammario, contrastando gli androgeni che la inibirebbero.
Un aumento dell'attività estrogenica può essere dovuto ad un aumento della SHBG (globulina legante gli ormoni sessuali), in quando essa si legherebbe con maggiore affinità agli androgeni, lasciando liberi di agire gli estrogeni, e da un aumento dell'attività aromatasica conseguente ad una maggiore secrezione di ormone follicolo stimolante (FSH) o di gonadotropina corionica umana (hCG) o a un eccesso di tessuto adiposo, senza dimenticare i casi di iperprolattinemia.
Ginecomastie fisiologiche
Le ginecomastie fisiologiche sono principalmente quella neonatale, puberale e quella legata al climaterio maschile.
Nel neonato la ginecomastia riflette semplicemente l'azione degli ormoni materni e placentari, ovvero estrogeni e prolattina.
Nel soggetto in fase puberale, invece, è frequente riscontrare la ginecomastia (dal 30 al 50% dei casi). Può essere uni o bilaterale e generalmente regredisce spontaneamente nell'arco di 1-2 anni quando vengono raggiunti stadi più avanzati di maturazione puberale.
Per quanto invece riguarda gli uomini sopra i 65 anni, può comparire ginecomastia soprattutto nei soggetti obesi per una possibile alterazione del rapporto tra estrogeni e androgeni, in quanto si ha un calo fisiologico del testosterone (androgeno) e per un aumento contemporaneo di attività aromatasica del tessuto adiposo che trasforma gli androgeni in estrogeni.
Ginecomastie iatrogene

Un quadro di ginecomastia può essere causato da numerosi ormoni e farmaci che possono provocare un aumento di estrogeni o prolattina.
Farmaci come la cimetidina o lo spironolattone sono degli antagonisti dei recettori degli androgeni; i derivati dell'oppio sono parzialmente degli agonisti dei recettori estrogenici mammari, mentre per esempio gli psicofarmaci aumentano il livello di prolattina, favorendo quindi la comparsa di ginecomastia.
Ginecomastie patologiche
Un quadro di ginecomastia può essere sintomatico sia di un disordine endocrino che di altre malattie riguardanti altri apparati.
È presente infatti ginecomastia in circa il 50% dei pazienti con sindrome di Klinefelter e ipogonadismo primitivo di altra origine, per una prevalente compromissione della secrezione di testosterone rispetto alla produzione di estrogeni.
La ginecomastia può anche essere il segno di un tumore testicolare (tumore delle cellule del Leydig, coriocarcinoma) o delle surreni che secernono steroidi sessuali e/o gonadotropina corionica umana.
Altre patologie alle quali si può associare la ginecomastia sono l'ipertiroidismo, la sindrome di Morris, i prolattinomi, alcune neoplasie non endocrine (come il carcinoma broncogeno).
Di frequente, la ginecomastia è associata all'epatopatia alcolica ma soprattutto alla cirrosi epatica. Un ruolo determinante infatti è svolto dall'iperestrogenismo determinato a sua volta dall'aumentata aromatizzazione dei precursori androgenici ad opera dell'alcol, dalla ridotta inattivazione epatica degli estrogeni, dal deficit della funzione delle cellule del Leydig del testicolo e dall'alterato trasporto proteico nel plasma.
Inoltre, si può riscontrare anche nei pazienti in dialisi per insufficienza renale.
Diagnosi
La diagnosi di ginecomastia è clinica. Vanno distinte le pseudo-ginecomastie, che sono dovute solamente ad un accumulo eccessivo di grasso in sede mammaria.
Utile per questa diagnosi può essere l'ecografia o la mammografia.
Utili sono anche gli esami di laboratorio, che devono essere ben mirati in base al sospetto clinico. Si possono infatti richiedere il dosaggio degli ormoni (estrogeni, prolattina, testosterone, gonadotropine, ormoni tiroidei) e gli enzimi che valutano la funzionalità epatica.
Terapia
Ovviamente la ginecomastia secondaria ad una condizione patologica si può trattare curando la patologia che sta alla base.
Come detto in precedenza, le forme puberali tendono a regredire spontaneamente e non richiedono quindi nessun tipo di trattamento. Se ciò non dovesse accadere, si ricorre all'intervento chirurgico.
L'impiego di antiestrogeni o inibitori dell'aromatasi (anastrozolo, letrozolo) ha dato risultati variabili da paziente a paziente.
Le forme iatrogene ovviamente tendono a regredire con la sospensione dei farmaci che le hanno causate.
Ultimi articoli sezione: Salute
Per prendersi cura dei capelli è importante conoscere quali nutrienti favoriscono la crescita, ne sostengono la resistenza e quali abitudini alimentari quotidiane li proteggono dagli agenti esterni.
Nel prediabete i livelli di glucosio nel sangue sono troppo elevati per essere considerati nella norma ma non tanto da essere classificati come diabete.
Asma grave: comprendere i sintomi e le opzioni terapeutiche
L'alimentazione come alleata del benessere: 5 cibi "irritanti" per le vie urinarie da conoscere
Disturbi alimentari e obesità: una relazione sorprendente di cui si parla ancora poco
La dermatologia moderna vive una stagione di straordinarie innovazioni tecnologiche e metodologiche che stanno rivoluzionando l'approccio alla cura della pelle.
L’autunno è ormai arrivato e, con esso, i classici malanni stagionali: per evitare di ammalarsi è dunque necessario adottare alcune buone abitudini e cercare di rafforzare le difese immunitarie.
Con l'arrivo dell'autunno, è comune notare un aumento della caduta dei capelli, un fenomeno che può destare preoccupazione.
Accedi ai servizi gratuiti
Se sei già registrato, clicca qui per accedere ai servizi gratuiti:
- Database Alimenti
- Calcola Ricetta
- Slot Machine
Altrimenti, clicca qui per registrarti gratuitamente.
Novità da Cibo360 TV
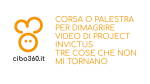
CORSA O PALESTRA PER DIMAGRIRE?

BRUCIA 500 kcal in 30 MINUTI? BALLE!

Qualità delle proteine

Grana Padano o Parmigiano-Reggiano?